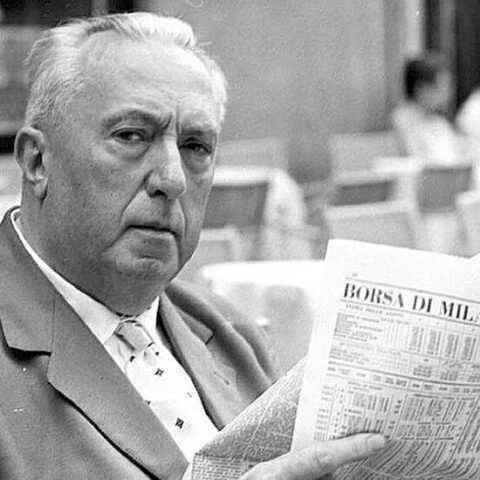C’è del marcio un po’ ovunque, dalla Terra dei Fuochi alle isole del Pacifico, non solo in Danimarca, come sosteneva Amleto, che del paese scandinavo fu fantasmagorico e pallido principe, nel suo più celebre monologo di lucida follia. D’altronde la grandezza di William Shakespeare, autore della più citata tragedia teatrale di sempre, sta proprio nel suo saper essere sempre ovunque, al di là di luoghi e tempi, per dirla con il critico polacco Jan Kott:


«Shakespeare è come il mondo, o come la vita. Ogni epoca vi trova quello che cerca e quello che vuole vedervi».
Mondo malato
Elementi umani, non umani e più che umani, animali, piante, isole, mari, tempeste vendicative, folletti, nuvole, mostri, spiriti, il mondo malato di Re Lear; non sono meri sfondi ma esseri complessi mai univoci e per questo universali. Ecco perché il Bardo è (e sarà sempre) nostro contemporaneo e concittadino. Ed ecco perché, secondo Shaul Bassi, occorre fare Shakespeare nell’Antropocene, come recita il sottotitolo del suo Pianeta Ofelia, prezioso volume edito da Bollati Boringhieri.
Complessità popolare
Nell’epoca in cui ci ritroviamo a fare i conti con un rapporto alterato, contraffatto, impazzito con il pianeta che abitiamo, scrive Bassi, la complessità paradossalmente popolare di Shakespeare è quanto di più necessario per comprendere la portata del cambiamento climatico, scenario dell’improbabile e dell’impensabile. Se il romanzo è il regno del probabile ed è quindi, forse, anche per questo meno facilitato a raccontare la follia della crisi climatica (colpa che Ghosh imputa agli scrittori e ai letterati quando scrive La grande cecità), il teatro shakespeariano ha la bizzarra capacità di fondere probabile e improbabile, finito e infinito, cultura e natura.
Riutilizzo creativo
E se, come diceva Harold Bloom, Shakespeare è colui che “ha inventato l’uomo” (inteso come genere umano, ndr), il Bardo fu anche un maestro di riciclo ante litteram: i suoi personaggi sono quasi sempre già esistenti, frutto di adattamento e upcycling, riutilizzo creativo. Amleto, Lear, Romeo e Giulietta: li prendeva da novelle medievali italiane, da cronache di storia antica poco accessibili ai più (almeno nella sua epoca) e li trasformava, li faceva rinascere, dava loro nuova vita rendendoli “personae” universali e popolari, capaci di arrivare a tutti, ovunque.
Dedicato a Ofelia
Maestro di metamorfosi, le sue opere ci portano dritti al senso dell’adattamento, il meccanismo biologico e sociale alla base dell’evoluzione. Scoprendo l’eco-ansia di Amleto, che lo porta all’inazione, scopriamo anche Ofelia, a cui il libro (e il Pianeta) è dedicato, che invece presagisce.
Controcampo ideale del principe di Danimarca, la donna protagonista, secoli dopo, del celebre quadro di Millais, è quasi ossessionata dalla vita vegetale (come d’altronde anche Gertrude, che difatti canterà Ofelia da morta insieme ad elementi naturali), di cui conosce e capisce il linguaggio.
Oltre la retorica di madre natura
Una capacità, la sua, che le rende possibile immaginare un altro mondo, complesso. Un codice alternativo a quello della corte danese: per Bassi, che cita saggi di Cacciari e Cavarero, la centralità di Ofelia va oltre il suo essere anti patriarcale, perché scavalca lo stereotipo “madre natura” banalmente utilizzato (non solo in ambito cattolico o conservatore, ma anche da molta cultura ambientalista) quando si descrive la donna, vista come generatrice, dunque totalmente nell’ottica di un pensiero retrogrado che le impone la maternità come funzione principale e scopo essenziale di vita.
Tragedia a colori
Il codice botanico di Ofelia ci parla della sua complessità, che unisce e travalica confini naturali e culturali. D’altronde le piante che ben conosce sono curative, ma anche abortive. Non sarà mai la “mamma” come da copione. A Ofelia, la ragazza morta in acqua, è dedicato il capitolo viola, di questo splendido libro diviso in colori. Ofelia è viola come certe piante acquatiche, evoca figure anfibie, fiori misteriosi e complessi. Ma viola è anche il colore che si adatta alla sua controparte, Amleto: il colore dei raggi ultravioletti di un patologo forense come quelli delle serie tv, che, appunto, vede marcio e putrefazione ovunque.
Pianeta blu
E così il verde è il colore del Sogno di una notte di mezza estate, spazio “erboso” in cui si incrociano mondi che travalicano i confini dell’umano, il blu è quello della Tempesta, del mondo dei mari, che va oltre la tendenza (banale, abusatissima) di identificare ecologia e natura con il verde. Il colore predominante sul nostro pianeta è proprio il blu, come le acque che coprono la maggior parte del globo. Blu come un oceano che non possiamo mai conoscere del tutto, aperto, a tratti spaventoso e vendicativo, dove coloniale e post coloniale, umano e non umano si fondono, in Ariel, Calibano, Prospero e Miranda.
Antropocene a Venezia
Il grigio è il colore di re Lear, scritto da Shakespeare durante la piccola era glaciale e in piena peste, zona dai contorni mal definiti, come l’epoca in cui «i pazzi governano i ciechi». E infine il rosso è il colore di Venezia, città dove sono ambientati sia Otello che Il mercante di Venezia. Spazio paradigma dell’Antropocene, la città è protagonista del capitolo più ricco del libro: “rosso come il sangue delle vite che vi si intrecciano”, tra passato e futuro, mito e decadenza, terra e acqua, cosmopolitismo e razzismo.
Lucido e visionario
Tra citazioni e intuizioni, il libro di Bassi, professore ordinario di letteratura inglese alla Ca’ Foscari, è lucido e visionario come i protagonisti shakespeariani. Non propone di (ri)leggere il Bardo in chiave didattica o pedagogica, come precursore dell’ambientalismo, né di spiegarci “cosa vuol dire”, dato che di certo sappiamo solo ciò che “ha detto”. È un saggio che si legge come un’escursione in territori che pensavamo di conoscere ma che scopriamo diversi, più ricchi, interessanti e quindi spaventosi.
Linfa per il futuro
Una Wunderkammer cromatica, che ribalta la tirannia del verde, colore della Natura ma anche del greenwashing, della gioventù, e insieme dei serpenti, della malattia, della gelosia e dell’invidia di Jago, per spingerci a considerare tutte le sfumature di un’opera immensa, complessa e popolare.
Nella quale rifugiarci e da cui attingere nuova linfa vitale per affrontare un futuro quanto mai incerto.