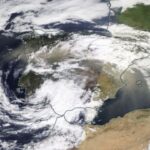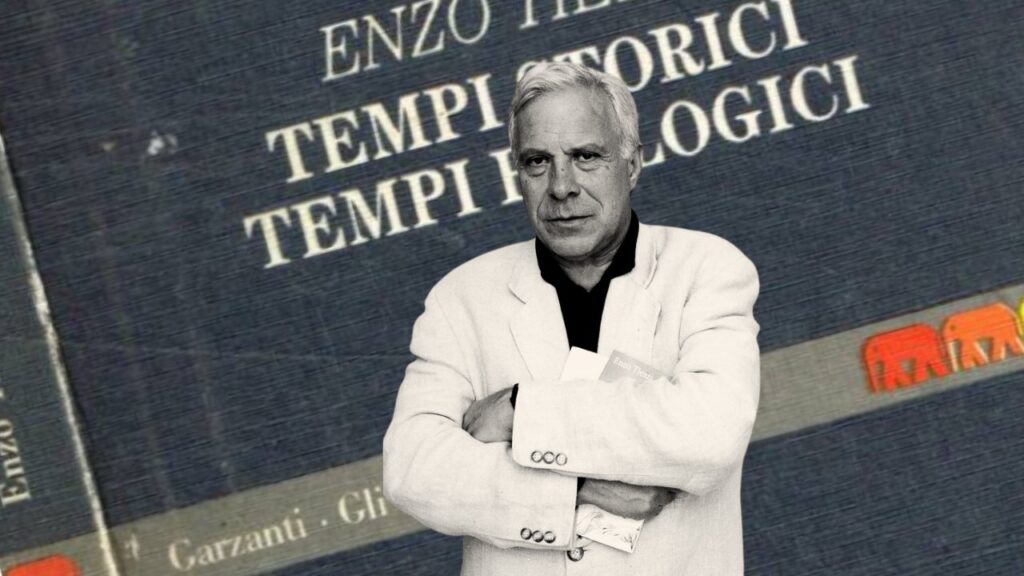È mancata a modo suo, ieri sera, nella sua casa di Cefalù. Senza preavviso, come aveva sempre compiuto le proprie scelte. Chiedendo a sua figlia Shobba, l’unica delle tre che l’ha seguita nella professione da fotografa, di continuare a ritrarla, anche durante gli ultimi giorni. A Letizia Battaglia si lega un’idea prepotente della fotografia. Se lei non ci fosse stata, con tutta l’anima e il corpo che ha riversato nella sua passione da narratrice visiva, nella sua arte al servizio dei diritti civili, dell’umanità, della legalità, se non si fosse imposta, da donna e giornalista visiva, con il suo desiderio di raccontare i fatti e le persone, i morti ammazzati e gli arresti, se non si fosse presentata puntuale con la sua macchina al collo ogni volta che serviva, tante scene di mafia, sulle pagine del glorioso quotidiano “L’Ora” di Palermo, semplicemente non le avremmo mai viste.
A partire da quella, giustamente celebre, in cui Sergio Mattarella prendeva fra le braccia suo fratello Piersanti, presidente della Regione Siciliana, subito dopo l’omicidio perpetrato dai sicari di Cosa nostra, nella tarda mattinata del 6 gennaio 1980.
Letizia giunse per prima sul posto e documentò quei momenti allucinanti con alcuni scatti di straordinaria intensità, che commuovono ancora oggi, specialmente se si pensa alla reporter, allora 45enne, agire sul campo, con la sensibilità e la lucidità da cronista che l’ha sempre caratterizzata, i capelli biondi a caschetto, gli occhi puntati su quell’uomo, suo coetaneo, insieme al quale si spegneva una stagione di speranza.
Visualizza questo post su Instagram
Si parla di Letizia Battaglia come della fotografa che raccontò la lotta alla mafia ed è certamente vero (“Shooting the mafia” è il documentario della regista inglese Kim Longinotto che ne ripercorreva, nel 2019, la vita e le opere). Ma in realtà lei è andata oltre. Ha partecipato in prima persona attraverso il suo racconto sempre ravvicinato, puntuale, appassionato e difficile, perché è difficile raccontare la morte, alla lotta contro la cultura mafiosa. Le sue immagini passate alla storia in questo campo non si contano, compresa quella in cui Giulio Andreotti conversava con il boss Nino Salvo all’hotel Zagarella di Santa Flavia, nel giugno 1979, una foto meno bella di altre ma che bastò a provare, durante il processo che si sarebbe aperto vent’anni dopo, le relazioni fra l’esponente democristiano e la criminalità locale.
Uno di quei racconti di morte le tolse, almeno per un po’, l’energia o forse la voglia di restare nella sua Palermo, di essere presente in quella guerra: quando nel 1992 vide scomparire uno dopo l’altro, fra la strage di via d’Amelio e la bomba a Capaci, i giudici Falcone e Borsellino insieme alla scorta e ai familiari che li accompagnavano, immagini che lei non trovò la forza di mandare alla storia, che la lasciarono attonita, come racconta in una bellissima intervista su Atlante della Treccani, quasi inerme al cospetto di tanta violenza:
«Cosa avrei dovuto fotografare? Quei luoghi dilaniati sembravano la fine di una società, con macchine sventrate volate sugli alberi, e brandelli di corpi ovunque. Fu una cosa bruttissima. Ero lì, avevo la macchina al collo, ma non me la sono sentita di scattare. Questo lo sento dentro come una colpa, un limite, perché un fotografo ha il dovere di fotografare».
Ma con il suo obiettivo, quasi sempre in bianco e nero, Letizia Battaglia ha inseguito moltissimo anche la vita, i bambini in particolare, con un approccio poetico e allo stesso tempo da ricercatrice sociale che l’avvicina a Pasolini, basti pensare alla famosa “Bambina con il pallone” che fotografò poche settimane dopo l’assassinio di Piersanti Mattarella nei vicoli della Cala, il porto di Palermo: bambini che c’interrogano e ci responsabilizzano, che c’inchiodano con il loro sguardo al reale, magari cogliendoli nel lettone di una casa senza acqua né luce. Proprio da Pasolini del resto lei era partita, nel dicembre 1972, realizzando una serie di ritratti del poeta nella galleria Turati di Milano, raffigurandone la sofferenza mentre affrontava un contradditorio pubblico intorno al suo “I racconti di Canterbury”, reduce dall’Orso d’oro di Berlino e vessato dalla censura in patria.

E allora forse proprio così la Battaglia vorrebbe essere ricordata oggi: più che come la fotografa della mafia, di cui resta l’indelebile contributo storico e civile, come la fotografa della vita, anzi della “disperata vitalità” che ne avrebbe segnato fino agli ultimi istanti la biografia, contro ogni forma di omologazione e in difesa delle diversità, degli orizzonti inediti, delle nuove generazioni creative che allevava all’interno del “Centro Internazionale di fotografia” aperto pochi anni fa nei Cantieri culturali alla Zisa. Come un’attivista culturale, già dai tempi del Centro di Documentazione “Giuseppe Impastato” che aveva contribuito a fondare nel 1979, alla quale la politica forse stava stretta, nonostante la sua proficua esperienza a livello cittadino e regionale nei Verdi e nella Rete.
Letizia Battaglia è mancata, appunto, nella perfetta coerenza del suo essere. Come uno dei suoi scatti imprevedibili, irriverenti, all’età di 87 anni, senza far intuire l’imminenza dell’epilogo, anche in virtù della tempra con cui aveva affrontato la malattia che stava combattendo da qualche anno:
«Mia madre non si fermava mai – ha raccontato all’Ansa un’altra delle sue tre figlie, Patrizia – Malgrado le sofferenze e le difficoltà di movimento continuava ad avere tanti contatti, a partecipare a incontri anche all’estero e ad affrontare perfino lunghi viaggi».
Per conoscerne più da vicino il percorso d’arte e di vita si presenta, a breve, una preziosa opportunità. Le circostanze, infatti, hanno voluto che proprio durante i mesi scorsi la Rai abbia prodotto una fiction, di cui la Battaglia aveva seguito da vicino la genesi, dialogando con il regista Roberto Andò e con l’interprete Isabella Ragonese, palermitana come lei. Andrà in onda a maggio e resta, in qualche maniera, come il suo ultimo dono.