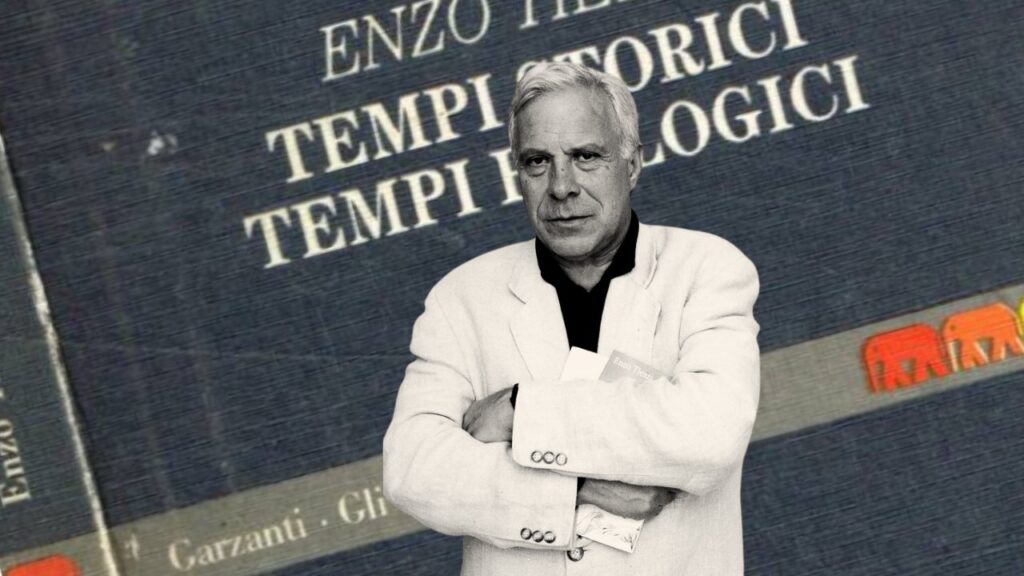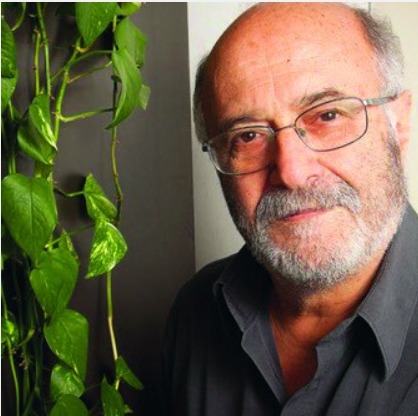«Cecilia e le streghe è l’opera prima di una scrittrice matura e compiuta, non già l’opera del solito esordiente di buone speranze», così Luigi Baldacci in “Epoca”, 11 luglio 1965. Benché vi sia una trama da noir, che prende le mosse da un misterioso incontro nelle strade deserte di Milano in una sera di mezz’agosto, “Cecilia e le streghe” è un’opera poetica, in molte sue descrizioni un omaggio a Milano, un atto d’amore di Laura alla sua città. È una Milano degli ultimi anni ’50, una visione fantastica quasi onirica, nella solitudine delle sere di mezz’agosto:
«Questa città ritorna a te dal mondo dell’infanzia, con le rondini della tua infanzia: una città color di rosa-fumo, di viola-fumo, di tenero neutro, “color di lontananza” come un verso dimenticato che appena appena ritorni alla memoria; ed è giusto che pudicamente si avvolga in teneri veli, ed è giusto che anche il suo cielo sia velato. E mentre vai pensando queste cose senti dentro di te come un senso di fratellanza per i rari passanti che camminano all’ombra delle antiche chiese».
Durante una sera come quella descritta, tornando a casa, Laura scorge una donna e una bambina. Un’immagine fugace, ma che lascia in Laura un senso d’inquietudine: nella donna c’è qualcosa di miserabile, di sconvolto; la bambina al contrario è ordinata, fiorente, con un nastro bianco fra i capelli come usava quando anche Laura era una bambina, e il prodigio delle rondini si ripeteva tutte le sere della bella stagione. Laura non resiste alla tentazione di avvicinarsi: si accorge che nell’abbigliamento della donna non c’è niente di lacero o indecoroso, però i capelli sono grigi e, benché giovane, il viso è terreo e scavato.

Laura si presenta: è medico, domanda se può aiutarla. Cecilia – questo il nome della donna – ha trent’anni e tre anni prima si è ammalata di cancro polmonare. Operata e apparentemente guarita, da qualche mese il tumore si è diffuso in tutto l’addome con metastasi molteplici. Ha lasciato Pisa, la sua città, è venuta a Milano per un consulto o forse è partita per sfuggire alla famiglia, a quelle reticenze, a quegli inganni, a quelle menzogne quotidiane. È venuta con la figlioletta Tea (Teodora, Rosa Tea la chiamerà Laura). Questa la storia, che Cecilia racconta con uno squisito accento toscano, con un’aria di leggero distacco, di discrezione e di civiltà:
«Mi tornava alla memoria il paesaggio toscano, con la sua pulizia, la sua nitidezza, il suo saper racchiudere i drammi umani in un disegno leggero».
Laura Conti ci descrive l’incontro a un anno di distanza, dopo essere stata soggiogata per mesi da Cecilia, «la donna cortese che andava incontro alla morte con la semplicità di una contadina e la grazia di una dama». Con l’abituale sensibilità e una spietata lucidità indaga i rapporti affettivi, l’ambiguità dei rapporti tra sano e malato, la pietà verso il malato, un sentimento che delude Laura, e persino le suscita un certo risentimento giacché «la sua essenza è fatta di promesse non mantenute».
L’incontro con Cecilia si dipana in una lunga meditazione sulla morte, «sopra questo avvenimento senza tempo e senza storia che è ammalarsi e morire» e si intreccia coi grandi problemi del dolore, della fede e dell’eutanasia. In questa trasposizione letteraria di un episodio della sua vita di medico, Laura Conti ha voluto togliere l’ammalato alla concezione comune che di lui si ha, «come di una persona senza più possibilità di vivere storia, di fare storia, ma solo di morire». Dopo un’assidua frequentazione, Cecilia scompare. Passa la primavera e torna l’estate nel cielo di Milano. Così come la morte tergiversa con Cecilia, Cecilia tergiversa col male. Nel susseguirsi di rinvii che la malattia concede a Cecilia, si concentra l’esito della vicenda che porterà a una rivelazione che apre un nuovo incubo:

«Credetti che la strada di Cecilia e la mia strada si intersecassero, in quella sera solitaria di mezz’agosto, ma non era vero: e quel che mi aveva affascinata in Cecilia era, benché io non lo sapessi, il suo procedere inarrestabile lungo le vie di un destino non solo imposto, ma imposto e scelto insieme. Imposto dall’interno e dall’esterno, dalle cellule maligne che si moltiplicavano anarchiche nei suoi tessuti, infiltrando, invadendo, uccidendo; e dal mondo esterno che stringeva intorno a Cecilia maligne e cieche barriere filistee; ma insieme scelto dall’interno, dai suoi pensieri e dai suoi gusti e dai suoi sentimenti e dalle sue volontà. Ora lo so, e so che non avrei potuto in alcun modo entrare nel gioco di così complicate determinazioni, un gioco duro e stretto, rapido sul filo di un esiguo margine di vita; un gioco già iniziato al tempo del nostro incontro, e anzi già quasi concluso: del quale non potevo che essere spettatrice, se pur lontana e indiretta: Cecilia geme e piange e impreca e si vergogna, in qualche tana del deserto d’asfalto, laggiù. Di tra le griglie della persiana vedo, in un cielo di pallida nebbia estiva, caldo e umido come un sospiro, le grigiazzurre guglie del Duomo, come un sospiro delicate.
Laggiù Cecilia nasconde il dolore e la collera e la vergogna: a me non manda che quelle che intravvedo sul marciapiede di fronte, perverse e disperate, impazienti e sospettose messaggere: le streghe».
Clicca e segui l’evento in diretta