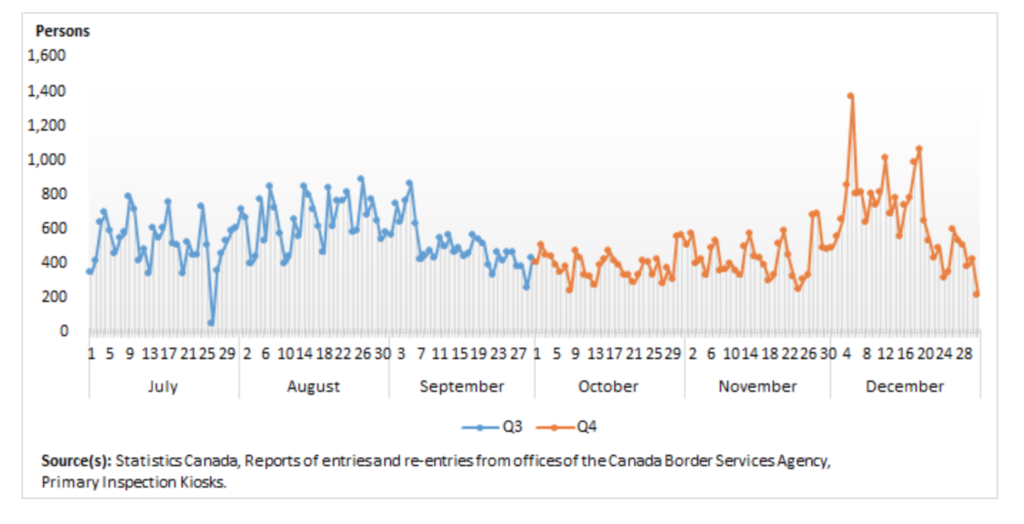Nominare il mostruoso, l’informe. Saperne guardare l’abisso. Intuirne la natura, scolpita in cima alle vette dell’etica, dove il bene è troppo distante dal respiro quotidiano degli uomini perché essi possano davvero cercare di raggiungerlo senza approdare ad assurde, smodate, cupe caricature. Trasformare il rimosso in azzardo fatalmente esposto ad eterogenesi dei fini. Sono solo alcuni precetti d’un’ipotetica morale per amorali volgarizzata dalla letteratura, dal cinema, dall’arte attraverso la maschera efficace e popolare del proibito per antonomasia, l’anonima creatura nata dalla fantasia della scrittrice Mary Shelley e spesso associata al cognome del suo squinternato realizzatore: Victor Frankenstein.

Il romanzo del 1818 conobbe ogni forma di rivisitazione. Il primo tentativo di adattamento per il grande schermo compie novant’anni. A dirigere la fortunata pellicola del 1931 fu James Whale e il volto dello spaventoso gigante provvisto d’elettrodi sporgenti dal collo e d’un’orrida cicatrice sulla fronte fu incarnato dal britannico Boris Karloff. Nel corso dei decenni anche la scena teatrale si è misurata con la suggestione abbagliante di un’esistenza a rischio zero, contenuta nella fosca utopia shelleyana della vita riproducibile, sezionabile, reinventabile in laboratorio depurata dalle sue odiose storture.
La penna esperta dello scrittore Francesco Niccolini, ad esempio, ha disegnato la traiettoria drammaturgica di differenti lavori. In uno degli ultimi, dal titolo Doctor Frankeinstein, in scena prima della chiusura generalizzata di cinema e teatri, Francesco Aiello e Fabrizio Pugliese indugiano nel grottesco e nel surreale e riaffacciano su un imponente e meticoloso impianto scenografico di cupezza ottocentesca e post-atomica desolazione il crudo campionario d’elettriche violenze tra il mostro e il suo sventurato inventore. L’insaziabile brama di perfezione dello scienziato lo induce a moltiplicare gli esperimenti per rimuovere ogni limite al proprio arbitrio, alimentando l’illusione di una perfezione manipolabile finché non abbia raggiunto il suo vertice estremo ed estinto ogni residuo di morte. Egli, tuttavia, crea esseri sempre più imperfetti e le sue convinzioni claudicano incerte, balbettando la voglia d’eliminare gli esiti fallimentari di un’occupazione folle e incoraggiando al contempo, tra sentimenti di contrariante vitalità, un oscuro e ingiustificabile amore per le sue deformi creature.
L’ultimo dei malnati rimessi in vita dal potere della tecnica perché sottratti artificialmente a quello della natura è sofisticatissimo eppure troppo distante dai desideri di suo padre. La scena è claustrofobica. La riempie un’atmosfera sulfurea figlia d’un meccanismo innaturale attivato da una telecamera indicante un tempo immobile scisso in ripetuti e identici frammenti di pellicola che descrivono un rapporto malato.
Guarda il trailer di Frankenstein, del 1931
Il vecchio uomo di scienza, in sedia a rotelle, con le caviglie spezzate dalla furia della sua ultima ingenerata foggia di mala prole confezionata per errore e la bestia informe dalla voce disperata e blasfema, venuta al mondo per esserne rifiutata. Entrambi sono colpa e origine l’uno dell’altro. La catena di negazioni e divieti che hanno tentato di infrangere li stringe in una speculare prigionia. Le volontà si urtano aspramente nella maledizione dell’inumano divenuto umano e nell’asfissia provocata da bizzarri ingranaggi e strumenti insufficienti a consacrare le scoperte dell’insano dottore e troppo algidi per le incontrollabili passioni del suo indegno erede. Quest’ultimo chiede ricordi e l’affetto di una donna, per emanciparsi da un’ incompiutezza turpe e priva di vita reale.
Ha una fisicità spinta da spasmi e tic, ottimamente incarnata da Fabrizio Pugliese e un ghigno tenero e diabolico sotto il buio inquietante di uno sguardo vuoto.
Il quotidiano di cui è parte gli riserva una concatenazione d’atti programmati, di voluttà apprese, di intenzioni ammaestrate. Lui stesso è un’ipotesi scientifica da verificare in un perenne riesame dei progressi ottenuti. Vive, o meglio si guarda vivere, in una dimensione goffamente sperimentale. Rappresenta l’involontario innescarsi di un congegno gabellato per vicenda viva. Avrebbe voluto percepire una sensazione vera, una memoria di sé non barattabile con pavloviani premi o punizioni. Sorprenderà, in un respiro soffocato, una certezza autentica come il vigore delle sue mani, capitata per caso nell’insistenza di ciechi automatismi e sottolineata provvidenzialmente dalle parole finali di Blade Runner:

“Tutti i miei momenti andranno perduti come lacrime nella pioggia. È tempo di morire”.
La durezza dello spettacolo è quella di una virtualità dilagante dove paiono sbiadire le separazioni e l’ineluttabile compiersi delle azioni racconta una sorta di comune stupidità dell’uomo e della macchina. Oggetti che brandiscono altri oggetti e ne abusano, in una reciproca ignoranza della fine.