In questi giorni si susseguono petizioni e dibattiti sul voto, sugli esami, sulla valutazione. Ed è forse una buona occasione per riflettere non solo sul senso del voto in una situazione di emergenza, in cui la disuguaglianza sociale e culturale è stata amplificata e la relazione educativa è stata a volte ridotta a un fare lezioni e assegnare compiti, ma sul senso in generale della valutazione educativa.
Come si svolgeranno gli esami di Stato in presenza e in sicurezza. La mia risposta al Question time: https://t.co/HfYpH8B2Fl
— Lucia Azzolina (@AzzolinaLucia) May 6, 2020
La valutazione educativa in Italia, e in molte altre nazioni anche se non tutte, assegna il compito di valutare gli apprendimenti alle stesse persone che quegli apprendimenti devono costruire, e che diventano in questo modo anche i giudici del proprio operato. E non sempre questo ruolo – valutare il proprio lavoro attraverso il lavoro di altri – viene riconosciuto come un’opportunità.
Valutare o misurare?
Ma è necessaria una valutazione? E se sì, a cosa è necessaria? Intanto sgombriamo il campo da possibili confusioni: valutare un apprendimento – sia esso frutto del nostro lavoro di educatore o di insegnante o frutto del lavoro di qualcun altro – non vuol dire misurare.
Una misura è «Il valore numerico attribuito a una grandezza, ottenuto ed espresso come rapporto tra la grandezza data e un’altra della stessa specie assunta come unità (unità di misura), e determinato con opportuni metodi o strumenti di misurazione», come si legge nella definizione della Treccani.
Per l’apprendimento non si hanno unità di misura. Il voto è quindi l’espressione sintetica di un giudizio di valore, un giudizio su quanto è stato appreso e su come lo si è appreso. In Italia usiamo la scala da 0 al 10, dallo 0 al 30 per l’Università, in altri paesi si usano le lettere, da F ad A, valore più alto, ma il senso rimane lo stesso: gli effetti dell’educazione – quello che scuola o università sono riusciti a ‘tirar fuori’, o meglio ad ‘allevare’ e ‘far crescere’ – possono essere descritti e rilevati, anche se non misurati, per poi essere messi su una scala a cui si attribuiscono dei giudizi sintetici (sufficiente, buono, etc..) o dei voti.
Percorsi di trasformazione
Ma indicare con numeri dei giudizi di valore non ne fa una misura: i dati di partenza non sono né misurabili né ‘oggettivi’, e le cosiddette prove oggettive, anche i test internazionali di cui mi sono occupata per anni, si limitano ad eliminare la soggettività dell’attribuzione del voto, che è sostituita dal punteggio predeterminato, ma mantengono l’arbitrio della scelta delle domande considerate significative, scelta che rimane del valutatore, anche se nelle prove internazionali si cerca, attraverso ampie discussioni e prove sul campo, di garantirne la neutralità e l’intersoggettività.


Eppure la valutazione è un elemento indispensabile, soprattutto in una visione dell’educazione formativa e trasformativa, per cui la chiave del successo è il cambiamento che il percorso educativo riesce ad ottenere. Un cambiamento nelle conoscenze che si è in grado di utilizzare, ma soprattutto nelle relazioni che tra esse si costruiscono, nella rete di connessioni tra teoria e pratica che permette di operare trasformazioni nei propri contesti di vita, o addirittura trasformazioni nella visione del mondo, nell’insieme di relazioni e di valori che ognuno, anche inconsciamente, anche da bambino, applica nella vita quotidiana e nella costruzione della propria identità.
Educare “sedendosi accanto”
In un processo educativo di questo tipo la valutazione dovrebbe offrire a bambini e ragazzi in crescita, e quindi in continuo cambiamento, un sostegno su cui avvolgersi, raggi di luce che indichino le direzioni verso le quali svilupparsi, la fiducia in sé stessi che permette di continuare a impegnarsi, evitando di trasformarsi in strumento di potatura e di selezione. Una valutazione formativa che in Italia dovrebbe far parte della cultura della scuola e degli insegnanti fin dagli anni ’60.
Ridurre le distanze di Cristiano Corsinihttps://t.co/qduXWRtyPO
— Gli asini (@gliasini) April 17, 2020
Per una valutazione di questo tipo viene in aiuto la parola inglese più usata nella valutazione educativa – assessment – che, come ricorda Cristiano Corsini sulla rivista Gli Asini sembra aver origine dal latino assidĕre, sedersi accanto, pratica utile non solo per il valutato, ma anche per il valutatore che può così meglio comprendere cosa non è stato capito di quello che ha cercato di spiegare.
Strumenti di sostegno
E può anche essere utile la metafora che proponeva Lawrence Stenhouse, educatore e pedagogista inglese degli anni ’70, quando ricordava agli insegnanti che per costruire un curricolo – non seguire il programma, ma costruire quel percorso che avrebbe permesso l’apprendimento di quelli che nel programma sono i punti centrali – la cosa più importante non era definire dove posizionare l’asticella ma scegliere i metodi e gli strumenti più utili ed adeguati alle esigenze di chi deve imparare a saltare.
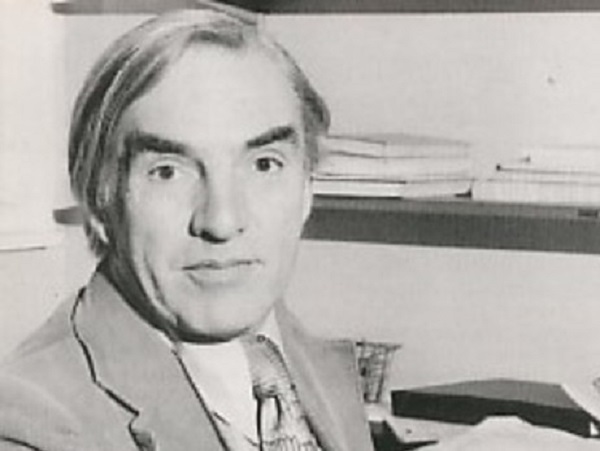
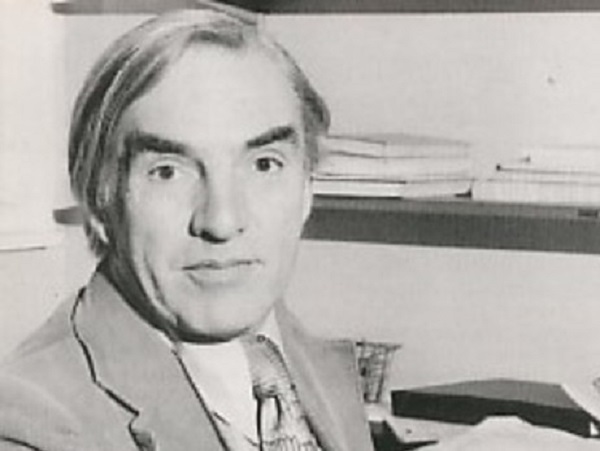
Valutazione quindi utile e indispensabile, strumento di crescita per lo studente e di ricerca per l’insegnante, che deve raccogliere i dati e rifletterci sopra per poter svolgere il proprio ruolo di sostegno e non di giudice. Valutazione come ricerca di indicatori che mostrino che il percorso proposto ha un senso, che i bambini o i ragazzi non solo sono in grado di seguirlo, ma che stanno esplorando, per proprio conto, scorciatoie o vie più ampie e panoramiche.
Competenze per la vita
In quest’ottica, valutare le conoscenze apprese – con un test o un testo scritto, con una discussione a più voci o con un’interrogazione – non basta, bisognerà capire anche quanto queste conoscenze si sono inserite in un contesto logico complessivo, in un Sistema di conoscenze possibilmente non solo disciplinare, e quanto sono diventate utilizzabili in contesti diversi da quelli affrontati in classe e via via più complessi. Occorre cioè valutare se e quanto le conoscenze, i meccanismi di pensiero, di calcolo, di uso della lingua che si è cercato di insegnare, si siano trasformate, come auspica l’Unione Europea (2018) ma anche la nostra Strategia per lo Sviluppo Sostenibile, in competenze, cioè in una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti che lo studente sarà in grado di utilizzare nella vita.
Guarda il video sull’istruzione di qualità della Strategia per lo Sviluppo sostenibile
Per valutare un cambiamento nelle competenze non basteranno allora quelle che von Foerster, un noto cibernetico, chiamava “domande illegittime”, quelle domande cioè in cui praticamente si chiede di ripetere quello che è già stato detto o assegnato come studio, ma bisognerà sforzarsi di porre domande vere, domande legittime a cui lo studente dovrà cercare di trovare la sua risposta. E incoraggiare e premiare le risposte non banali.
Macchine non banali
È quella che viene chiamata anche ‘valutazione autentica’ o per compiti di realtà. Compiti che difficilmente vengono proposti nella nostra scuola, soprattutto nella scuola secondaria superiore, in presenza come a distanza.


Come ricordava Von Foerster (1987), al mondo troviamo numerose macchine banali, una lampada ad esempio, o un’automobile, per cui ad un dato input corrisponde sempre lo stesso output, ma anche numerose e imprevedibili macchine non banali: tutti gli esseri viventi. A volte sembra che lo scopo della scuola e della valutazione sia trasformare imprevedibili macchine non banali in macchine banali.

























