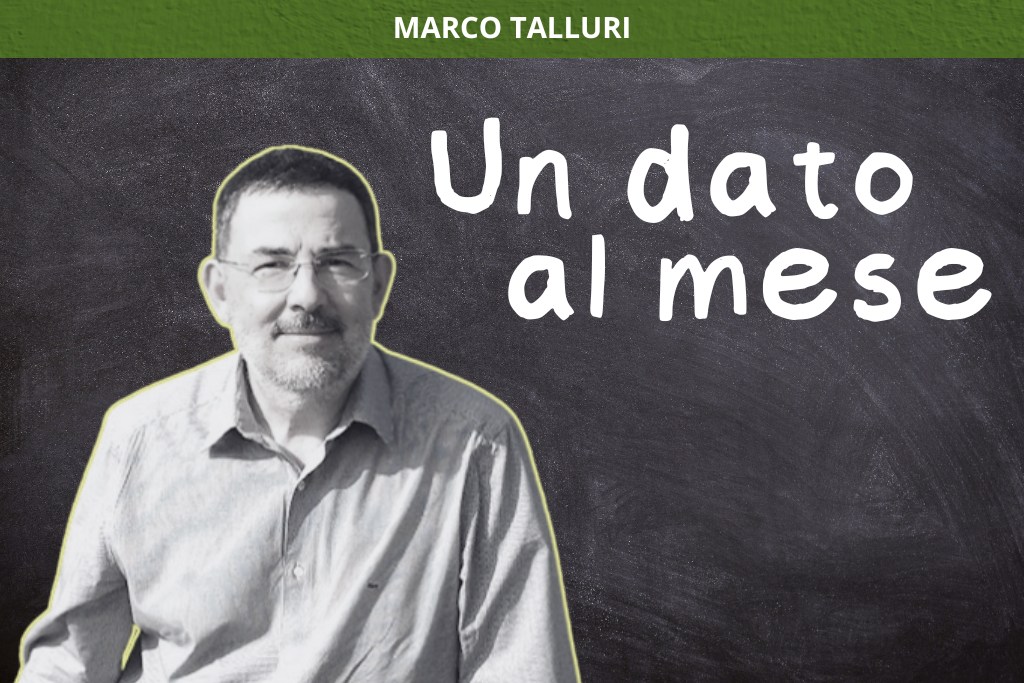La scuola italiana sta reagendo alla sfida del “restiamo a casa” e lo sta facendo con impegno. Ma quello che cerca di fare, ciò che è invitata a fare dal governo e dalla società, è portare avanti i programmi, non rimanere indietro, non certo di riflettere assieme, insegnanti e studenti, sui saperi, sulle visioni del mondo che la scuola propone e che in qualche modo fanno parte, sono complici, della crisi che siamo chiamati ad affrontare.
Il caos rivelato dal virus
Quello che s’insegna a scuola, e ancora di più all’Università, deriva dall’ipotesi che sia possibile studiare il mondo e la sua complessità suddividendolo in pezzi, in mappe – le discipline –, per poter poi studiare un pezzo alla volta, e ricostruire il tutto come fosse un puzzle. Il progresso scientifico degli ultimi 200 anni ha diffuso l’illusione che il mondo sia prevedibile, come una macchina da poter montare e smontare a piacimento, eppure chi si occupa di teoria del caos o di epidemiologia, di ecosistemi o di cambiamenti climatici, sa che il mondo delle sicurezze e della prevedibilità, promesso alla fine dell’800, ha lasciato il posto ad una visione caratterizzata dalla complessità, dall’incertezza, dall’interconnessione tra tutte le componenti di un sistema, il cui limite ultimo è il Pianeta intero.
Guarda il video sulla Teoria del coas e l’effetto farfalla.
Riconoscere la complessità
Sappiamo da diverso tempo – anche se non entra nei nostri insegnamenti, neanche universitari – che le mappe, le discipline, non potranno mai cartografare il mondo, e che occorre costruire, o ricostruire, le relazioni che legano uno all’altro i saperi che abbiamo accumulato. A partire dalla scuola, che può cominciare a riflettere sulle metafore, sui modi di pensare, che implicitamente propone, e che questo evento straordinario mette in discussione:
- per prima cosa sul fatto che il Pianeta non è una macchina. E non c’è bisogno di rifarsi all’ipotesi Gaia di James Lovelock per rendersi conto che è un sistema complesso, costituito da esseri viventi a loro volta complessi, indissolubilmente intrecciati, la cui risposta alle perturbazioni è nella gran parte dei casi imprevedibile
- poi sulla visione del sapere, dei saperi, come isole di certezza in un oceano d’incertezza, come propone Morin sulla consapevolezza della provvisorietà delle nostre conoscenze e dell’imprevedibilità di quello che in futuro scopriremo( I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Cortina Editore, 2001). Come dice Hans Jonas (Il principio responsabilità, Piccola biblioteca Einaudi, 1990): «Quando Cartesio ci raccomanda di assumere come falso tutto ciò che può essere messo in dubbio conviene al contrario, di fronte a rischi di tipo planetario, di trattare il dubbio come certezza possibile e quindi come un elemento fondamentale della decisione».
- per arrivare a una rivalutazione dell’ignoranza, come elemento di consapevolezza fondamentale per prendere decisioni sensate: «(…) l’ignoranza è utilizzabile, anzi utile ed indispensabile, per la conoscenza di noi stessi e dei nostri rapporti con il nostro ambiente. La coscienza della nostra ignoranza può costituire l’inizio di una nuova saggezza per quel che concerne il nostro posto nel mondo contemporaneo». (J. Ravetz, Connaissaince utile, ignorance utile, in Theys J. et Kalaora B. (Eds) La terre outragée. Les experts sont formels! Edition Autrement, Paris, 1992).
Guarda l’intervista a Edgar Morin, filosofo e sociologo francese
Rivalutare l’ignoranza
Sapere quello che non sappiamo è l’arma che stiamo, come homo sapiens, utilizzando in questo momento contro il coronavirus, per non lasciare al caso, e alle leggi dell’evoluzione, la sopravvivenza di una parte dell’umanità.
Ma questa esperienza ci sarà utile se impariamo ad usare questa stessa arma in altre situazioni che minacciano la nostra specie, anche se con tempi più lunghi: la perdita di biodiversità e l’invasione da parte della specie umana di tutti gli habitat del Pianeta (probabile causa del coronavirus), l’inquinamento atmosferico (probabile fattore aggravante) e, ovviamente, i cambiamenti climatici.
Queste sono le sfide che l’Antropocene, l’era dell’uomo, ci pone davanti. Andare avanti con i programmi scolastici non basta, occorre usare questa opportunità per discutere, tra insegnanti ed educatori e con i ragazzi, di visioni e metafore, di stili di vita e di responsabilità, di competitività e di solidarietà.
Che cos’è l’antropocene? Guarda il video