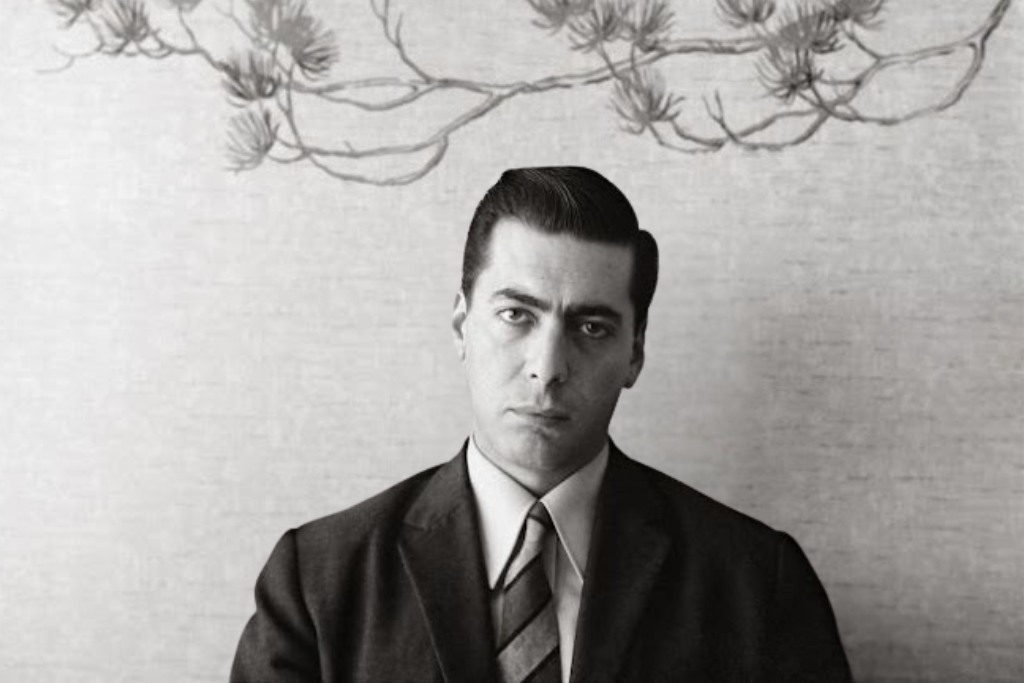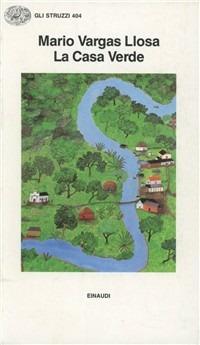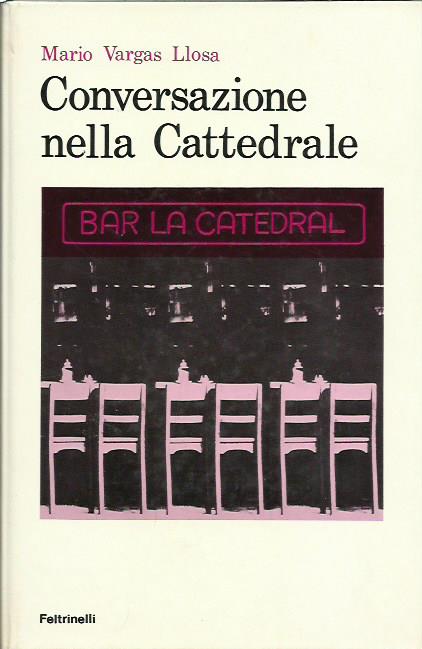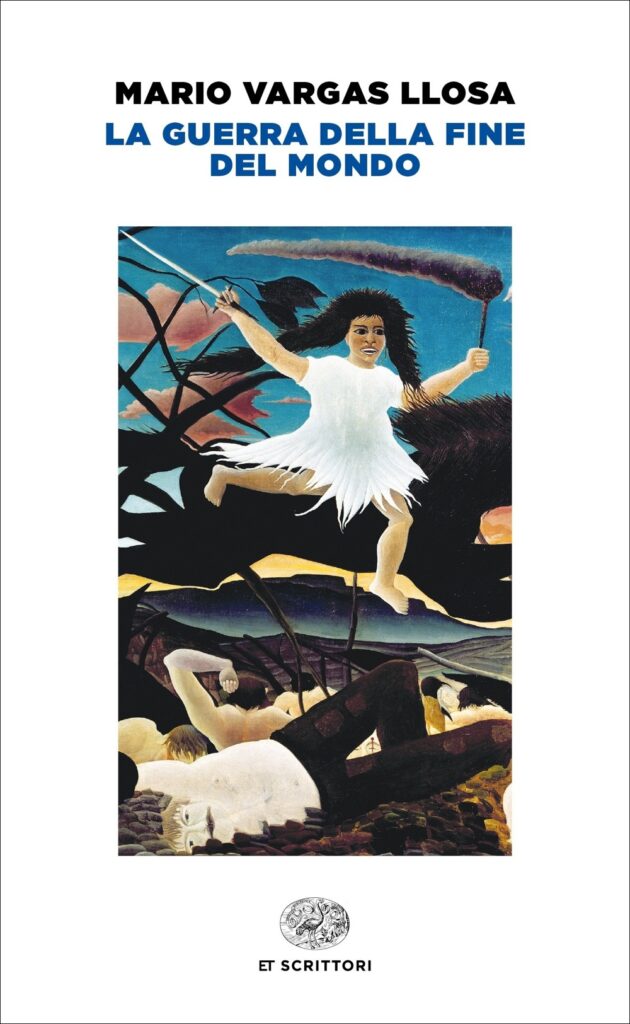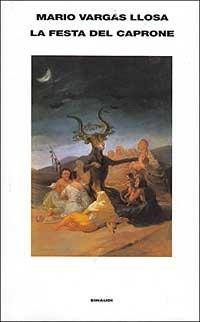Senza libertà non esisterebbe la letteratura, aveva detto in un’intervista all’Ansa nel 2021, in occasione della sua venuta a Roma per la Fiera della piccola e media editoria “Più libri più liberi”, sottolineando come la letteratura sia sempre, in una società, simbolo e indicatore di libertà, perché: «Quando c’è libertà la letteratura fiorisce e quando viene meno soffre moltissimo». Una convinzione sulla quale Mario Vargas Llosa, morto a 89 anni il 13 aprile (la famiglia ne ha dato notizia solo parecchie ore dopo) nella sua Lima, aveva basato non solo praticamente tutta la sua abbondante opera letteraria, ma la vita stessa.
La precoce passione per la letteratura
Nato nel 1936 a Arequipa, nel Perù meridionale da una coppia alto borghese che si separa poco dopo la sua nascita (al piccolo Mario fu raccontato che il papà era morto; scoprì la verità circa dieci anni dopo, quando incontrò il padre, iniziando con lui un rapporto che fu sempre molto problematico), il fluviale scrittore peruviano scopre molto presto la passione per la letteratura: «Ho imparato a leggere a cinque anni ed è la cosa più importante che mi sia successa nella vita», disse in apertura della lectio del 2010 a Stoccolma, quando ritirò il Nobel per la Letteratura.


Folgorato da Madame Bovary
A 23 anni, nel 1959, nonostante i tentativi paterni di distoglierlo dal demone letterario, culminati nella “reclusione” nel collegio militare Leoncio Prado (che racconterà in La città e i cani), arriva a Parigi e in una piccola libreria del Quartiere Latino, o almeno così narra la leggenda da lui raccontata, si imbatte in Madame Bovary, lo compra e lo legge in poche ore, restandone “vampirizzato”. «Erano anni che nessun romanzo vampirizzava così rapidamente la mia attenzione», racconterà infatti in seguito, riferendosi a quanto il capolavoro di Flaubert gli avesse cambiato la vita. Trova nel grande scrittore francese il maestro, padre putativo letterario che cercava e capisce «quale scrittore mi sarebbe piaciuto essere» e che «da quel momento e sino alla morte avrei vissuto innamorato di Emma Bovary», come spiegherà anni dopo, nel 1975, in L’orgia perpetua, saggio il cui titolo cita una frase di Flaubert («Il solo modo di sopportare l’esistenza è stordirsi nella letteratura come in un’orgia perpetua»).
I primi romanzi
I primi libri, La città e i cani, La casa verde e Conversazione nella Catedral, sono ritenuti fondamentali dalla critica, non solo per il loro valore letterario ma perché contribuiscono al cosiddetto boom della letteratura sudamericana, fenomeno planetario che vide Vargas Llosa tra i maggiori protagonisti, insieme a Cortazár, Roa Bastos, e all’amico nemico (di Llosa) Garcia Márquez (e poi, successivamente, Jorge Amado, Isabel Allende, Roberto Bolaño etc). La città e i cani, pubblicato nel 1963, fu un esordio effettivamente esplosivo: ambientato tra i cadetti del collegio Prado di Lima (i cani, i “perros” del titolo si riferisce proprio a come venivano chiamati gli allievi del terzo anno), è un romanzo che, intrecciando flashback di reminiscenza quasi faulkneriana, racconta storie di dispotismo e sopraffazione (bullismo, si direbbe oggi), in netto contrasto con le apparenti, ipocrite norme educative.
Il libro, fortemente autobiografico e con un protagonista principale che è chiaramente l’alter ego dell’autore (che spiegherà poi: «Ero un bambino viziatissimo, presuntuosissimo, cresciuto, faccio per dire, come una bambina… Mio padre pensava che il Leoncio Prado avrebbe fatto di me un uomo, ma per me fu come scoprire l’inferno») irrita non poco ufficiali e cadetti peruviani, che ne bruciano le copie nelle piazze di Lima, accusando Vargas Llosa di calunnia.
Gli anni con Fidel
Negli stessi anni lo scrittore comincia l’impegno politico, che lo caratterizzerà sempre, anche se in modo per molti versi sorprendente, e che reputerà sempre essenziale per chi fa letteratura. Socialista, appoggia la lotta armata come strumento di liberazione (sono gli anni delle rivolte contro i paesi colonialisti in Africa e dei movimenti rivoluzionari centro e sud-americani. Appoggia Fidel Castro e la rivoluzione cubana ma fino al 1971, quando interrompe ogni rapporto con il partito comunista de L’Avana e con il leader maximo, dopo l’arresto del poeta Heberto Padilla che aveva criticato il governo. Proprio questo episodio e la successiva petizione per la scarcerazione di Padilla, almeno così si dice, fu causa della rottura con Garcia Marquez. La disputa culminò nel 1976 con un plateale pugno in faccia, di cui però non volle mai rivelare il vero motivo, a scapito dello scrittore colombiano.


La svolta liberista
In seguito, tra la fine degli anni ’70 e gli anni ’80 (periodo in cui nel frattempo pubblica La zia Julia e lo scribacchino, La guerra della fine del mondo, Chi ha ucciso Paolino Molero?, Il narratore ambulante), Vargas Llosa si trasforma, incredibilmente, in liberista, arrivando addirittura, molto discutibilmente (soprattutto con il senno di poi, guardando alle conseguenze che quell’ondata reazionaria di iper liberismo hanno avuto nei decenni, sino ad oggi) a simpatizzare per l’opera di Margaret Thatcher, responsabile di aver smantellato, a suo dire, l’eccesso di burocrazia statalista. Nel 1988 (in Perù sono gli anni di Sendero Luminoso e di rinnovate tensione politiche che non di rado sfociano in attentati e rapimenti) si candida a presidente del Perù a capo del Fronte Democratico, coalizione di centrodestra il cui programma economico era non di ridistribuire e meglio le ricchezze (come lo scrittore aveva caldeggiato da giovane, negli anni della militanza progressista), ma di eliminare il “parassitismo” statale, incentivando la libera iniziativa.
Il trasferimento in Spagna
Ma lo scrittore è un corpo estraneo anche all’interno della coalizione: niente affatto religioso, favorevole all’eutanasia e alla libertà sessuale, Llosa si scontra con i suoi nuovi compagni di partito. Perde le elezioni, vinte dall’allora semi sconosciuto ingegnere Alberto Fujimori, un indipendente di centro che solo pochi anni dopo, con una sorta di spettacolare golpe interno, sopprime tutte le libertà costituzionali e diventa a tutti gli effetti un dittatore, restando in carica fino al 2000. Llosa nel frattempo, solo pochi giorno dopo la sconfitta, stizzito aveva lasciato il Perù per trasferirsi prima in Francia e poi in Spagna.
Cartografia del potere
Il nuovo secolo inizia con La festa del caprone, del 2000, una riflessione sulla tirannia (tema che Vargas Llosa non ha mai smesso di affrontare) ambientata nella Repubblica Dominicana all’epoca del dittatore Trujillo. Del 2003 è Il Paradiso è altrove, doppia biografia di Paul Gauguin e soprattutto della nonna del pittore, la peruviana Flora Tristan, una delle fondatrici dei primi movimenti femministi europei, mentre nel 2006 esce Avventure della cattiva ragazza, ambientato tra gli anni ‘60 e ‘80 tra Londra, Parigi e Madrid. La storia, romanzata, di Roger Casement, l’irlandese che nei primi del ‘900 denunciò il genocidio belga in Congo e quello del Putumayo in Amazzonia, è al centro de Il sogno del celta, nel 2010. È questo l’anno in cui gli viene assegnato il Nobel per la letteratura «per la sua cartografia delle strutture del potere e le sue immagini taglienti della resistenza, della rivolta e della sconfitta dell’individuo», come si legge nelle motivazioni.
Contro ogni regime
Questa cartografia, in effetti, Vargas Llosa l’ha portata avanti, tenendola stretta tra le mani, per tutta la vita; le sue contraddizioni, le infatuazioni politiche, gli abbagli, non hanno mai posso di un centimetro la sua opposizione a ogni forma di regime, seppure in modo talvolta confuso e incredibilmente contraddittorio, dato che negli ultimi anni aveva simpatizzato addirittura per Bolsonaro e Milei. Si tratta, come raccontava Sandro Veronesi in un intervento a Fahrenheit su Radio 3 , di un altro tipo di coerenza, strabiliante, a tratti incomprensibile e sicuramente molto discutibile, ma di certo non ottusa.


Spirito inquieto
Da bravo personaggio novecentesco quale è stato, Vargas Llosa ha vissuto di cadute e riprese, attraversando il secolo breve e parte del nuovo millennio. Nel discorso con cui ha ritirato il Nobel aveva tenuto a ribadire la sua assoluta fede nella scrittura come antidoto al totalitarismo, e nella letteratura come impegno: «La letteratura introduce nei nostri spiriti l’insofferenza e la ribellione, che stanno dietro a tutte le imprese che hanno contribuito a diminuire la violenza nei rapporti umani. A diminuire la violenza, non a eliminarla. Perché la nostra sarà sempre, per fortuna, una storia incompiuta. Ecco perché dobbiamo continuare a sognare, leggere e scrivere: il modo più efficace che abbiamo trovato per alleviare la nostra condizione mortale, per sconfiggere il tarlo del tempo e per rendere possibile l’impossibile».
Aspettando il racconto postumo
Nel frattempo, il prossimo autunno sarà pubblicato da Einaudi, postumo, un racconto lungo, in corso di traduzione, nel quale Vargas Llosa si avventura in una Madrid del futuro, fantomatica e senza più cinema, biblioteche, musei, totalmente iper-tecnologizzata.
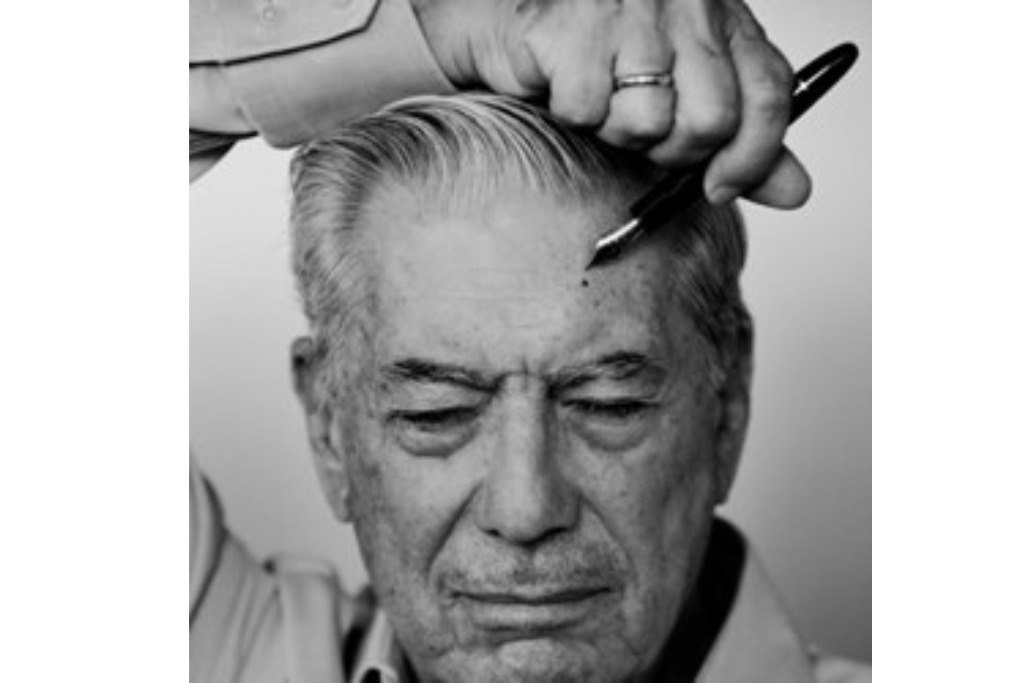
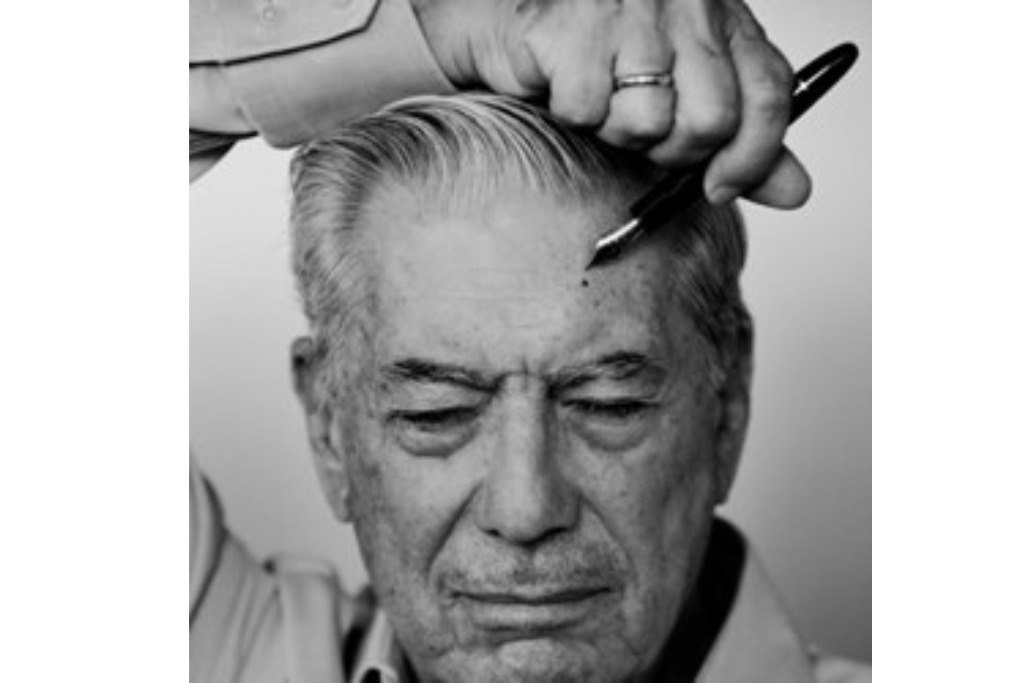
Aspettiamo di leggere l’ultima fantasia distopica dell’imprevedibile peruviano.