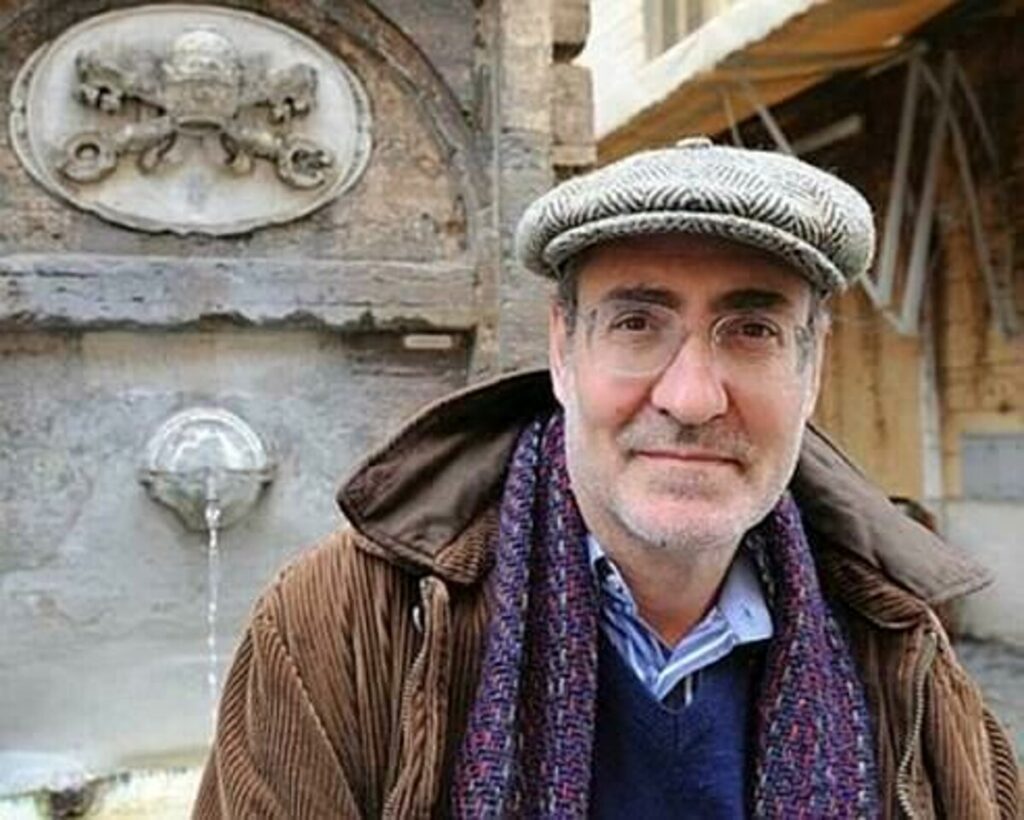Il paradiso è altrove, sempre. È il recinto dei giusti in cui è lecito immaginare che la vita sia migliore: gli amori ricambiati, le minoranze etniche rispettate, il pianeta e i diritti salvaguardati. È, “paradiso”, non solo il titolo di questo Verso il paradiso, ma anche l’ultima parola dei tre libri – perché di tre libri, in fondo, si tratta – dell’ultima, attesissima prova letteraria di Hanya Yanagihara, appena uscito in contemporanea mondiale e in Italia edito nella traduzione di Francesco Pacifici da Feltrinelli, con qualche piccolo refuso di troppo e un’accorta strategia di marketing a dir poco superflua. Perché questa terza opera della giornalista e autrice newyorkese di origini nippo-coreane e vissuta alle Hawaii, arriva dopo il planetario successo di Una vita come tante ed è, insieme ad un altro romanzo fluviale, Annientare di Michel Houellebecq, il libro cult del 2022. E invece ecco le bozze del libro impacchettate nella scatola disegnata da Ilya Milstein che riproduce la casa protagonista di Washington Square ed ecco l’account Instagram con tutte le immagini, le illustrazioni e le opere d’arte che possono accompagnarne visivamente la lettura. Al confronto, le borse di cotone riciclabili realizzate da vari artisti per Una vita come tante, sembra già un’operazione naïve.


To Paradise, come recita il titolo originale, è un libro corposo (768 pagine) e intenso, a tratti emozionante, tattico e sentimentale, destinato a creare schieramenti tra i lettori e i recensori. C’è chi lo accusa di essere manipolativo e falsamente complesso e chi, come Edmund White o il Guardian, ha già gridato al capolavoro del XXI secolo.
Yanagihara, della cui vita sappiamo forse troppo e non tutto ci bendispone (editor di Traveler per viaggi extra lusso, capo del supplemento di Moda & Design del New York Times, nome di punta dell’élite culturale newyorkese che decreta cosa è “in” mangiare, leggere e recensire mentre confessa di odiare New York e voler vivere a Kyoto) ha trasfuso in quest’opera ambiziosa molti dei temi a lei cari, a cominciare dalla pervasività delle relazioni omosessuali dei protagonisti, passando per l’autofustigazione, l’espiazione e il senso di colpa, la fragilità delle identità e delle relazioni, il coraggio di proteggere chi amiamo.
Ma il quadro di quest’opera va ben oltre lo scavo psicologico dei personaggi per consegnarci tre affreschi che arditamente riscrivono la storia, azzardano il futuro, interrogano l’antropologia e sviliscono le spinte di autoaffermazione dei popoli, in un intreccio di nomi che ricorrono, razze che si confondono e ruoli che si sovrappongono lungo i pannelli del trittico come in un racconto buddista sulla reincarnazione.


Tre sono infatti i momenti storici fotografati nel libro, a partire dal 1893. Siamo a New York, terra degli “Stati Liberi” dove il matrimonio tra omosessuali è legittimo a dispetto della rigidità tra le classi sociali. David Bingham è il giovane nipote di una facoltosa famiglia di finanzieri e a lui andrà la magione di Washington Square nel Greenwich Village dove vive col nonno.
David è orfano e diafano, sgomento e privo di qualità, al pari di tanti personaggi della letteratura classica di fine Ottocento e come la Catherine Sloper del romanzo di Henry James, Washington Square, che potremmo andarci a (ri)leggere per l’occasione.
Sarà solo la travolgente passione per uno spiantato e dubbio insegnante di musica a fargli desiderare di mollare gli agi per trovare veramente se stesso in California, in “paradiso”.
Visualizza questo post su Instagram
Nel 1993 David Bingham è invece un assistente legale di origini hawaiane, giovane amante del suo capo Charles Griffiths. Manhattan è assediata dall’Aids e mentre nella grande casa nel Village, trionfante di pezzi d’antiquariato hawaiano, si accompagna alla morte ormai prossima un vecchio fidanzato di Charles, arrivano da lontano gli echi dell’infanzia di David, nipote dell’erede al trono dell’arcipelago spodestato e soppiantato dall’annessione statunitense.
A Lipo-wao-nahele si rifugiò suo padre, irretito dal sogno delirante di una possibile ribellione secessionista e ora tragicamente e illusoriamente intento a ritrovare suo figlio, partito giovanissimo per l’America, per il “paradiso”.


E nel 2093 Washington Square si chiama Zona Otto e Charles Griffiths è lo scienziato co-creatore del regime totalitario in cui sono sprofondati gli Stati americani in cinquant’anni di pandemie e di guerre. Sua nipote Charlie, unica vera protagonista femminile del libro, è sopravvissuta e lesa, fragile, indifesa, tenace.
Ce lo racconta lei il mondo nuovo: le tute da raffreddamento, il razionamento delle risorse idriche e alimentari, il controllo assoluto delle relazioni sociali e dei pensieri, rivelando, nella parte più sostanziosa e toccante del libro, il futuro distopico verso il quale stiamo scivolando e tutto il coraggio di cui avremo bisogno per immaginare quanta libertà e giustizia occorrono per trasformare una terra qualunque nel “paradiso”.