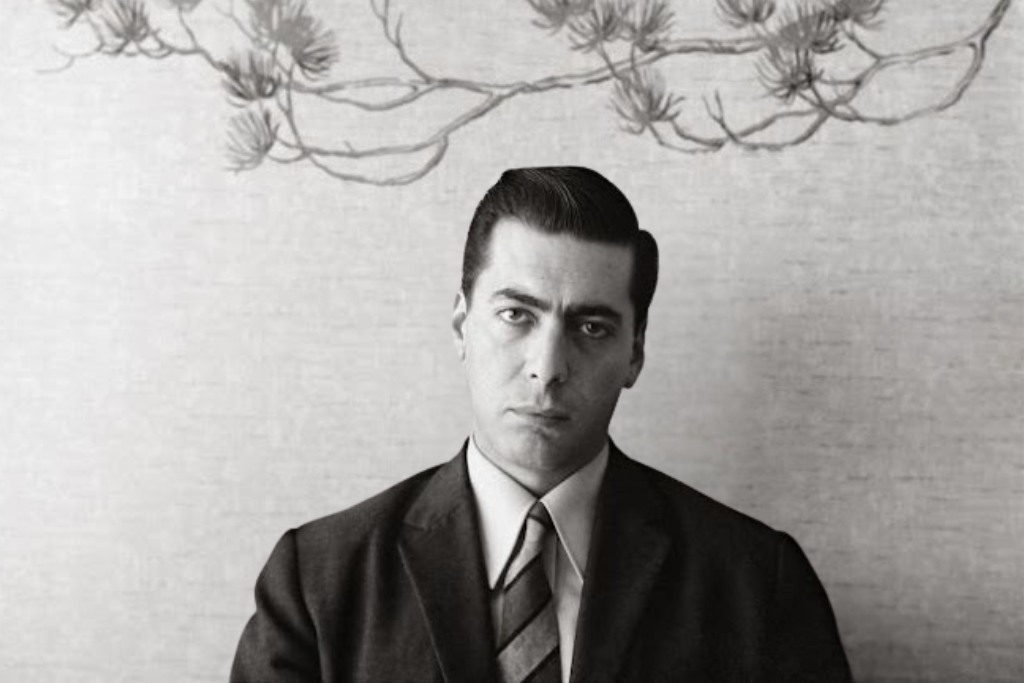A sei anni dal primo corteo del movimento per la Terra che portò in piazza migliaia di persone in tutta Italia, i Fridays for future sono tornati in piazza venerdì 11 aprile con un nuovo sciopero per il clima. Da Torino a Palermo, sono state circa 20 le città coinvolte dalla mobilitazione in tutta Italia. «Ci volete seppellire ma siamo semi», si legge sullo striscione in testa al corteo di Roma, mentre i manifestanti rivendicano le piazze ora che guerre e politiche di riarmo hanno fatto scivolare indietro le azioni per il clima nell’agenda politica.


No all’industria bellica, stop al cemento, impegni concreti contro l’aumento delle temperature e creazione di lavoro tramite la transizione ecologica, sono i temi al centro dello sciopero.
Riarmo e sfida climatica
Rispetto alla grande mobilitazione del 2019, i numeri dello sciopero sono più contenuti ma i temi rimangono vivi e si rinnovano. Nel discorso climatico entra ora con forza il pericolo che rappresenta il passaggio all’industria bellica per raggiungere gli obiettivi climatici. Le già poche risorse investite nella transizione ecologica saranno ancora meno, con il rischio di rendere irreversibile a breve termine l’inversione di rotta sull’aumento delle temperature globali.
Il 2025 si era aperto con la notizia, rilasciata dal Copernicus Climate Change Service, l’osservatorio per la Commissione Europea dei dati sul clima, che il 2024 era stato l’anno più caldo mai registrato a livello globale e il primo anno solare in cui la temperatura media globale aveva superato di 1,5 °C i livelli preindustriali, limite fissato negli Accordi di Parigi del 2015. Sempre l’osservatorio sul clima ha poi fatto sapere che il mese di marzo appena concluso è stato il più caldo mai registrato in Europa, con una temperatura media sul territorio europeo di 6,03 °C. Intorno ai 2,4 °C in più rispetto alla media di marzo del periodo 1991-2020.


L’impatto delle guerre
Le temperature continuano quindi a salire mentre in Europa si pianifica di portare la spesa per la difesa intorno agli 800 miliardi di euro. Per l’Italia si tratterebbe di arrivare al 2% del Pil indirizzato alla spesa militare. L’impatto dei conflitti sul clima non si limita al freno che l’economia di guerra imporrebbe alle strategie di conversione ecologica ma include anche un impatto diretto. Sebbene sia difficile per gli analisti quantificare le emissioni delle guerre, un rapporto del 2023 prodotto dalla società di consulenza climatica Climate Focus ha stimato le emissioni del primo anno di scontri armati in Ucraina in circa 150 milioni di tonnellate di anidride carbonica. L’equivalente delle emissioni prodotte dal Belgio nello stesso anno.


Alleanza con il lavoro
Rispetto ai primi passi della mobilitazione per il clima, il movimento si trova oggi a fare i conti anche con una realtà diversa che affronta una nuova crisi economica. Per questo, in occasione dello sciopero per il clima, è stata promossa una piattaforma in comune fra i Fridays for Future e il sindacato della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), che a Torino è sceso in piazza al fianco degli attivisti. C’è la ricerca di un’alleanza sociale che unisca la sfida climatica e la rivendicazione dei diritti occupazionali. Da questo punto di vista, la transizione energetica rappresenta un’opportunità economica, con saldo occupazionale positivo.
Come ricordano gli attivisti, diversi studi e programmi stimano che l’abbandono dell’economia fossile e il passaggio a un’economia con emissioni zero porterebbe circa 168.000 occupati temporanei e 17.000 occupati permanenti solo in Italia. Numeri ai quali vanno aggiunti poi i posti di lavoro necessari per attuare la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, le strategie di adattamento al cambiamento climatico e la ricerca.


L’ombra del pacchetto sicurezza
Intanto però, nello stesso giorno dello sciopero, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri il 4 aprile. Una volta bloccato in Senato, per mancanza di coperture finanziarie, e rinviato alla Camera, il governo ha deciso di tagliare corto sulle misure di sicurezza e trasforma il Disegno di Legge in Decreto-Legge, accorciando così l’iter di approvazione. Serviranno ora 60 giorni per convertire il decreto in legge.
All’interno del nuovo pacchetto sicurezza sono incluse misure repressive per chi manifesta che coinvolgono direttamente anche i movimenti per il clima e l’ambiente. Si inaspriscono, per esempio, le sanzioni per proteste e per i blocchi stradali, che da illecito amministrativo diventano ora reato. L’impedimento della libera circolazione potrà essere punito con la reclusione in carcere fino a un mese e una multa di 300 euro. La pena potrà andare dai 6 mesi ai 2 anni se commessa da più persone riunite, quindi durante una manifestazione.


Sanzioni agli ecoattivisti
Aumenta della metà anche la pena prevista per chi manifesta al fine di «impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici». Misure che fanno seguito alla legge approvata nel gennaio del 2024 che regola le Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Una legge rivolta direttamente agli ecoattivisti e che prevede multe da 10.000 a 60.000 euro, fino all’arresto.


Rumore di primavera
È in questo contesto che i movimenti per il clima tornano adesso in strada. La rete Extinction Rebellion Italia annuncia per la settimana dal 25 aprile al 1° maggio prossimi la mobilitazione Primavera Rumorosa «per la libertà, il lavoro e la giustizia climatica».
Un’iniziativa caratterizzata da azioni non violente, eventi e cortei, che prende il nome dal celebre libro di Rachel Carson, Primavera silenziosa.