La tempesta sui mercati finanziari mondiali, innescata dall’ondata di dazi e aggravata dalla deriva militarista delle politiche europee, segna un passaggio di fase drammatico. Mentre la finanza d’affari vacilla sotto i colpi di un’economia sempre più instabile, l’Europa rivede la sua stessa idea di sostenibilità, spingendo le banche d’affari a investire, anziché nei fondi Esg (Environmental, social, governance), nell’industria bellica. In questo scenario, l’unico argine sembra rappresentato dalla finanza etica: una finanza radicata nei territori, che investe nell’economia reale e nei diritti delle persone.


Simone Siliani, direttore di Fondazione Finanza Etica, ci aiuta a comprendere come siamo arrivati a questo punto. E come si possa guardare verso una nuova economia di pace.
La cronaca degli ultimi giorni ha messo in evidenza la fragilità della finanza speculativa. Le nuove politiche sui dazi introdotte e poi sospese da Trump minacciano forti ricadute anche nell’economia europea. Quali pericoli crede siano legati a questo tipo di politica economica?
I dazi sono uno strumento estremamente pericoloso. Introdurre logiche protezionistiche in un sistema globale così interdipendente è un azzardo. Nessun paese può pensare realisticamente di contenere l’intera filiera produttiva entro i propri confini. Si rischia un boomerang. Si parte convinti di essere in posizione di forza, e poi si scopre che la bilancia commerciale non è così favorevole come si pensava. E intanto, paesi alleati potrebbero reagire con ritorsioni, spostando i propri interessi verso altri mercati. In quel caso, gli Stati Uniti rischierebbero di danneggiarsi da soli, più di quanto non ne trarrebbero vantaggio. Il rischio aumenta se i dazi sono accompagnati da una politica estera aggressiva, come quella che Trump ha già dimostrato di preferire: penso all’idea di acquisire la Groenlandia o al controllo strategico del Canale di Panama. Se i dazi servono a giustificare queste mosse geopolitiche, allora si entra in una zona grigia pericolosissima, in grado di innescare squilibri globali difficili persino da immaginare.


Nel frattempo, i grandi fondi internazionali stanno progressivamente abbandonando i criteri Esg per orientarsi verso investimenti legati all’industria bellica, giustificati con il concetto di “sicurezza”. Dal vostro osservatorio, si tratta di una risposta temporanea alla crisi geopolitica o di un cambio di paradigma?
Temo che non sia affatto una risposta temporanea. Quello a cui stiamo assistendo è un cambio strutturale, un vero e proprio cambio di paradigma. È in atto una grande narrazione finalizzata a trasformare l’attuale modello economico, e questa trasformazione passa anche attraverso la militarizzazione della finanza. Faccio un esempio: il 19 marzo la Commissione europea ha presentato il White Paper con la European Defence Industrial Strategy 2030. L’apertura è esplicita ed è un richiamo alla deterrenza: «L’unico modo per garantire la pace è essere pronti a dissuadere coloro che vogliono farci del male». È una frase che segna un’inversione di rotta rispetto al passato, e che di fatto normalizza l’idea di una guerra permanente. Decisione che non è passata dal Parlamento europeo ma che la presidente Von Der Leyen si è assunta, appellandosi all’articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue). La cosa impressionante è che nell’incipit del documento non si fa mai riferimento diretto alla Russia o alla guerra in Ucraina. Si parla genericamente di “minacce” e “attori esterni” che minaccerebbero il nostro “modo di vivere“. Con la giustificazione di un’emergenza, eppure la guerra in Ucraina è in atto da più di tre anni, minacce dall’Artico al Baltico fino al Nord Africa, è in atto il progetto di mobilitare i risparmi europei a favore del settore bellico, rimuovendo ogni ostacolo normativo, anche quelli che oggi lo escludono dalla tassonomia verde e dai fondi Esg.
Ma se domani scoppiasse la pace, chi comprerebbe più armi? L’Ucraina oggi destina il 30% del Pil alla spesa militare, mentre paesi come Grecia e Polonia superano il 4%. È un modello che vuole reggere nel tempo, anche grazie alla spinta di potenti lobby industriali, assorbendo risorse, ma è un comparto molto limitato per dimensioni, imprese e capacità di occupazione nell’ambito dei settori produttivi europei. E intanto, in documenti ufficiali della Commissione, si invoca apertamente la necessità di cambiare le normative Esg e il Green Deal per rendere ammissibili gli investimenti nelle armi anche all’interno dei fondi sostenibili, ex articoli 8 e 9 della tassonomia europea. Se questa non è una rivoluzione del paradigma europeo, non so cos’altro lo sia. Ed è simile a quello che nel 1914 portò al primo conflitto mondiale, che nacque da una corsa al riarmo fra il Regno Unito e la Prussia di allora, su uno specifico settore degli armamenti che erano le navi da guerra.


Davanti a questo scenario, cosa possiamo fare? Come Fondazione Finanza Etica praticate da anni l’azionariato critico, intervenendo nelle assemblee di colossi come Leonardo e Rheinmetall.
Siamo convinti che ciascuno di noi può fare qualcosa. Noi lo facciamo con l’educazione critica alla finanza, nelle scuole, nelle università. Cerchiamo di spiegare perché è così determinante non stare a guardare e l’azionariato critico ci ha permesso di entrare nelle assemblee azionarie di quattro multinazionali coinvolte nel mercato degli armamenti, come Leonardo, Thyssen Krupp, Fincantieri e Rheinmetall. In questo modo abbiamo constatato, direttamente, come sia in atto una vera e propria operazione finanziaria, più che industriale. E infatti i numeri parlano chiaro: imprese come Leonardo o Rheinmetall hanno visto i propri titoli crescere in modo impressionante, in alcuni casi fino al +1000% in tre anni. L’andamento delle azioni dal 22 febbraio 2022, a ridosso dell’invasione russa dell’Ucraina del 24 febbraio vede Rheinmetall in testa, con un incremento astronomico del 1.142%.
Più distanziata ma pur sempre da record, Leonardo a +606%, seguita dalla partecipata Hensoldt con +443%. Thales ha realizzato un aumento del 191%, Bae Systems del 170%. Dal 2016 seguiamo da vicino Leonardo e il suo spostamento sempre più marcato verso la produzione militare: allora il 56% delle attività era civile, oggi siamo al 76% militare. La parte civile è ormai marginale. Lo stesso vale per Fincantieri: nel 2024 il 36% del business è stato militare, il resto riguarda navi da crociera e piattaforme. Nell’assemblea del 2024 hanno assicurato che manterranno questo equilibrio, ma sappiamo bene quanto ciò possa cambiare in fretta. C’è poi la questione Mbda, il consorzio europeo in cui Leonardo detiene il 25%. È Mbda France a produrre missili a media gittata con testata nucleare, ma le nostre domande circa il coinvolgimento di Leonardo Spa nel settore delle armi nucleari restano. L’Italia non ha ratificato il Trattato Onu per la proibizione delle armi nucleari, del resto abbiamo delle sedi Nato come Aviano e Ghedi dove sono presenti testate nucleari, e Leonardo continua a investire in questo consorzio.
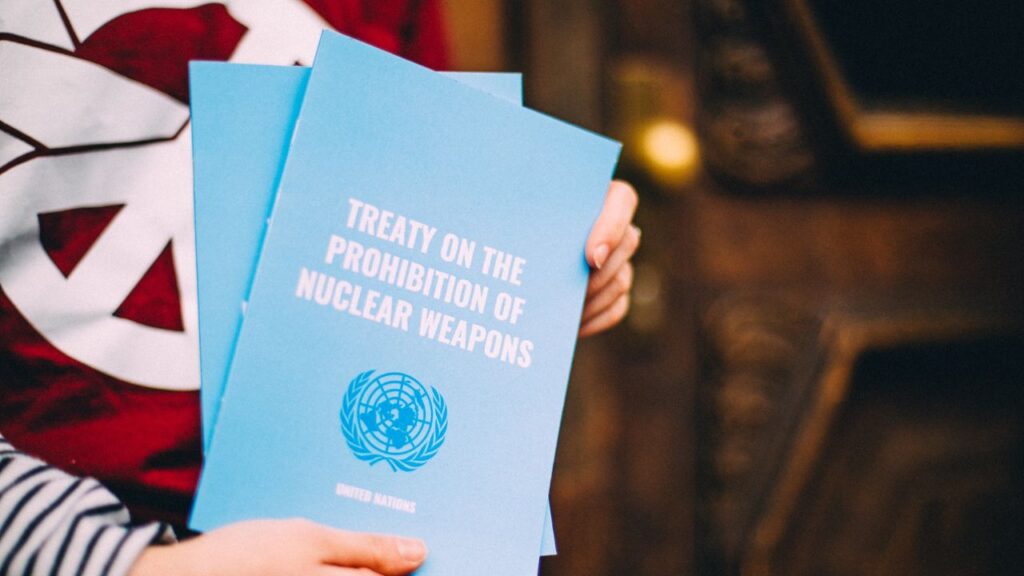
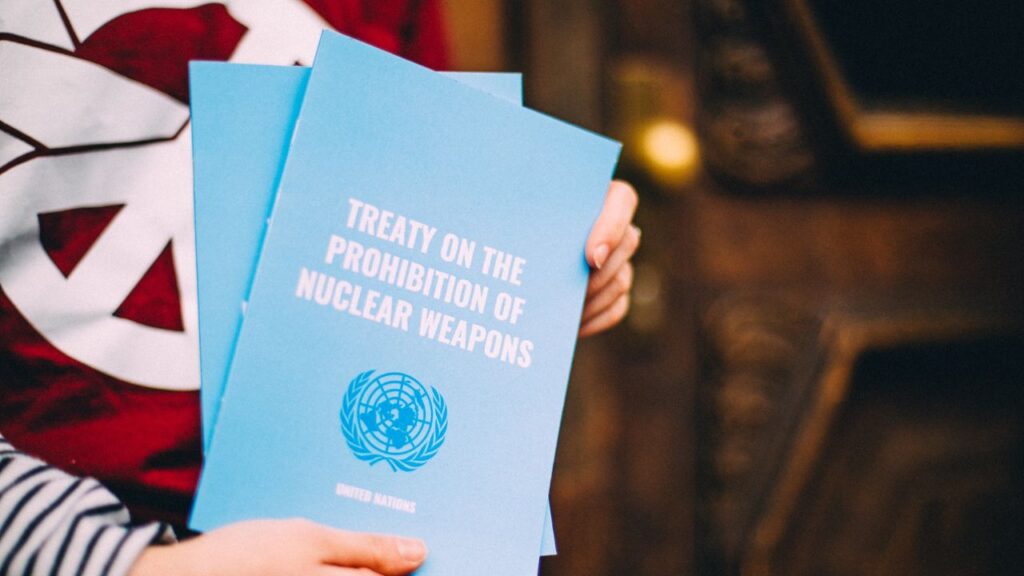
Quindi, quanto spazio c’è ancora per porre domande scomode e ottenere risultati concreti?
Non si tratta solo di fare opposizione, ma di creare consapevolezza. In ogni assemblea portiamo la voce dei cittadini, delle comunità, dei risparmiatori. L’azionariato critico è ancora uno strumento potente. Anche quando non ottiene risultati immediati. Senza dimenticare che i risparmiatori italiani possono chiedere alle proprie banche, come vengono investiti i propri fondi. Il nostro impegno è, quindi, quello di chiedere trasparenza, incalzare i consigli di amministrazione. Molti istituti di credito dicono di non finanziare imprese che operano nell’ambito della produzione di armamento nucleare, ma in realtà, spesso non hanno policy certe e verificabili. Con il progetto ZeroArmi, realizzato da Fondazione Finanza Etica in collaborazione con Rete Italiana Pace e Disarmo, abbiamo creato uno strumento per aiutare i risparmiatori a fare scelte consapevoli.
Il rating, infatti, analizza l’esposizione bancaria italiana verso l’industria delle armi, compresa quella delle banche socie di Banca Etica. Non pensiamo che dall’oggi al domani si possa cambiare, ma vedere istituti che inseriscono paesi che violano i diritti umani come la Turchia, nelle loro black list, è già un successo. Ricordiamo che in Italia è ancora in vigore la legge 185/1990, che il governo sta tentando di svuotare, che disciplina l’export di armamenti italiani. Il suo principio cardine è che non si possano esportare armi verso Paesi in stato di conflitto armato, a meno che non stiano esercitando il diritto alla legittima difesa, come definito dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ma, ci risulta, sia avvenuto nel conflitto israeliano-palestinese, con armamenti italiani esportati a Tel Aviv, come certificato dall’Agenzia Dogane.


Forse proprio i crolli azionari di questi giorni possono far capire la differenza tra finanza etica e finanza speculativa. Quanto è importante diffondere una visione che parta davvero dai valori dell’economia civile e sostenibile, mentre è in atto l’indebolimento del Green Deal europeo?
Abbiamo un grande potere del valore di diecimila miliardi di euro. A tanto ammontano i risparmi dei cittadini europei. Se decidiamo di non agire, siamo complici. Oggi è semplicissimo cambiare istituto, banca, fondo, ma bisogna mobilitarsi ed ognuno di noi può farlo. Bisogna tornare alla radice: la finanza deve essere al servizio delle persone, non dei profitti. E abbiamo una buona notizia. Oggi in Europa ci sono almeno ventisei realtà bancarie, tra cui Banca Etica, che praticano davvero una finanza non speculativa ma che sostiene l’economia reale, le piccole e medie imprese, le associazioni, i soggetti fragili, le donne. Funzionano molto bene, garantiscono che gli investimenti dei propri clienti vadano a sostenere progetti positivi per le comunità.
Non sono utopie, ma esperienze concrete: penso, ad esempio, all’accordo tra Banca Etica e la Banca Europea per gli Investimenti, che ha permesso un finanziamento da 60 milioni di euro destinato all’economia civile, che avrà una ricaduta nell’economia reale per almeno 165 milioni di euro. L’economia civile è in buona salute: se ciascuno di noi sceglie con consapevolezza dove mettere i propri soldi, il cambiamento è possibile.


Niente è ineluttabile, serve una vera economia della pace e il potere è nelle nostre mani.



























